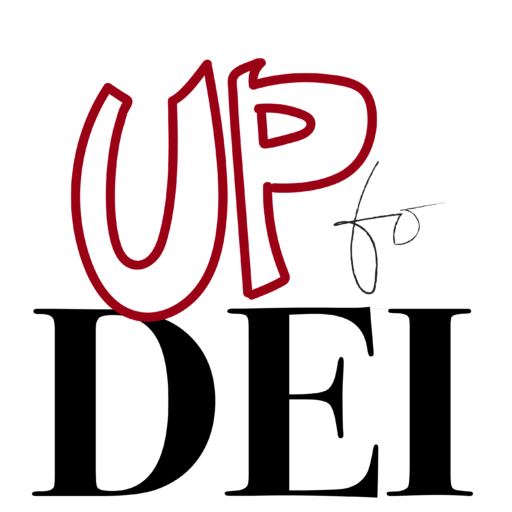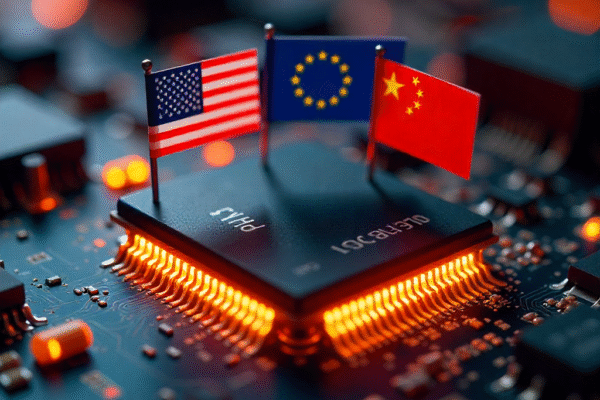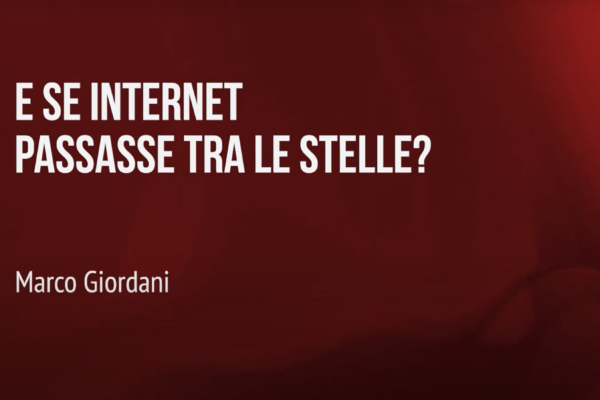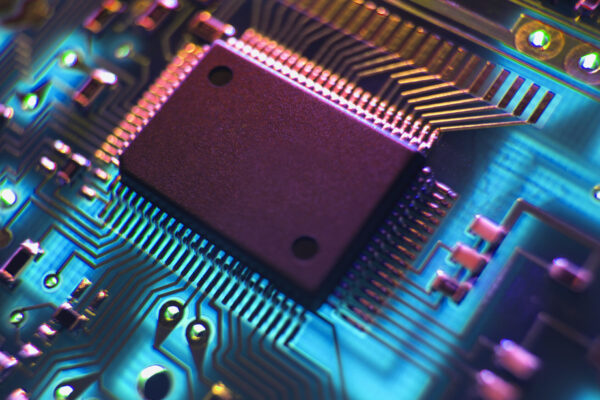
Microelettronica e globalizzazione: Qualche ombra sulla microelettronica europea
a cura di Alessandro Paccagnella Nel numero precedente di UpToDEI avevo messo in evidenza la crescita esuberante del mercato dei semiconduttori, soprattutto negli USA, trainato dallo sviluppo fenomenale dei data center per A.I. In questo contributo ci soffermerò su questa sponda dell’Atlantico e sulla attuale situazione. Se nell’anno 2000 ancora un quarto della produzione mondiale di chip a semiconduttore era localizzata in Europa, nel 2020 siamo scesi al 8%, perdendo un’ampia quota del manifatturiero soprattutto verso le Repubblica popolare cinese. Questa drammatica riduzione va associata a diverse concause, ma penso che la principale sia stata la perdita di memoria storica e di consapevolezza da parte dei governi europei, sia a livello comunitario che nazionale. La limitata produzione di chip in Europa non è una novità di questa decade. Già negli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo i paesi europei avevano accumulato un gap tecnologico con l’allora leader indiscusso in tecnologie e produzione, ossia gli USA, e si parlava di “egemonia americana” per descrivere la situazione che si era consolidata durante le prime due decadi della guerra fredda. Politici europei illuminati, e mi piace segnalare come gli italiani fossero in prima fila in questo movimento di pensiero – Altiero Spinelli e Amintore Fanfani per citarne un paio, a metà degli anni ’60 avevano cominciato a evidenziare i limiti di uno sviluppo industriale europeo che ci vedeva succubi verso le tecnologie più avanzate made in USA. La situazione era ulteriormente peggiorata a inizi anni ’70 con lo sviluppo dei circuiti integrati, prima bipolari e poi sempre più basati sui MOSFET, che videro nella commercializzazione del primo microprocessore (l’Intel 4004 a novembre 1971) e della prima DRAM (memoria dinamica ad accesso casuale, Intel 1103 a ottobre 1970) innovazioni tecnologiche strepitose e successi economici planetari, ma di aziende statunitensi. Le nazioni europee cercano di reagire ma senza coordinamento intereuropeo: ogni nazione cercava di supportare i propri campioni nazionali – il “particulare” di guicciardiniana memoria, anche tramite trattati o joint-venture industriali bilaterali con gli USA. La competizione fra i David europei e il Golia americano non si risolse come nel racconto biblico, ma con la conferma di una massiccia superiorità a stelle e strisce. Nel 1973 la produzione americana di circuiti integrati era 19 volte quella europea e le aziende statunitensi dominavano il mercato, con 8 aziende USA fra le prime 10 nella classifica dei maggiori produttori di semiconduttori a metà anni ‘70. Va a merito dei politici continentali degli anni ’80 del secolo scorso avere infine recepito le istanze per un supporto dell’industria dei semiconduttori sotto il cappello di un coordinamento europeo: a metà anni ’80 furono lanciati i primi fondi europei per finanziare progetti che coinvolsero svariati partner europei in azioni di ampio respiro scientifico e tecnologico internazionale, a partire dal I programma quadro del 1984. La robusta iniezione di capitali pubblici e privati europei stimolò la crescita delle attività di ricerca e sviluppo, sia in ambito accademico che aziendale, e proseguì – anche se perdendo parte del vigore inziale – per alcuni anni. Alla fine del XX secolo ben 3 aziende europee di semiconduttori erano fra le prime 10 a livello globale: STMicroelectronics (Italo-francese), Infineon (tedesca) e Philips (dei Paesi bassi), a testimonianza di un ambiente europeo che era diventato ecosistema accogliente per lo sviluppo delle tecnologie più avanzate e delle fabbriche più efficienti. Dall’inizio del XXI secolo la spinta, politica in primis, per supportare lo sforzo europeo nel campo dei semiconduttori scemò rapidamente, e in ambito industriale si privilegiò il ritorno economico immediato rispetto al costoso sviluppo di tecnologie e aziende nel vecchio continente, provocando una massiccia delocalizzazione delle produzioni verso lidi più accoglienti e soprattutto meno costosi, in primis la Cina. Lo sviluppo delle tecnologie microelettroniche più scalate, seguendo la riduzione della dimensione dei transistor associata ai nodi tecnologici al di sotto dei 100 nm, si arenò a metà della scorsa decade, quando anche il nostro ultimo campione – STMicroelectronics – decise di fermarsi nella corsa a chip sempre più densi e scalati. Conseguenze inevitabili furono una crescita modesta nella quantità di chip prodotti e una focalizzazione su mercati specifici, quali quelli per applicazioni automotive e industriali, basati su tecnologie meno scalate, le cosiddette tecnologie legacy, ma uscendo dal mercato dei microprocessori più potenti e delle memorie. Siamo arrivati così alla situazione odierna, in cui non vi è in Europa un solo produttore di chip di memoria o GPU, che come detto sopra fungono da traino del corrente sviluppo industriale della microelettronica. La crisi dei chip innescata dal Covid ha finalmente resuscitato l’attenzione dei politici verso una industria, quella dei semiconduttori, considerata strategica per lo sviluppo economico, sociale, tecnologico e militare: l’European chips act (2022) ha cercato di invertire la rotta. Purtroppo gli errori fatti negli anni ’60 e ’70 si sono ripetuti anche in questo inizio di XXI secolo, e pure il Chips act non ne è rimasto immune: fondi insufficienti, coordinamento europeo nullo, competizione fra nazioni per accaparrarsi le risorse, scelte di partnership tecnologiche sbagliate. Il primo EU Chips act non è riuscito a decollare (ne potremo vedere le ragioni in un prossimo intervento) e si sta già lavorando al successore, il Chips act 2.0, cui auguriamo migliore fortuna del precedente.